C’è una fase della vita femminile – tra i 45 e i 55 anni circa – in cui molte donne si ritrovano letteralmente “schiacciate” da richieste, ruoli e bisogni che si sovrappongono e si moltiplicano. La collega Laura Turuani, psicoterapeuta dell’Istituto Minotauro, nel suo libro Le schiacciate dà voce a questa condizione spesso silenziosa e sottovalutata, portandola alla luce attraverso un’attenta riflessione clinica e culturale.
Le donne della generazione X, oggi adulte, sono cresciute tra gli anni ’70 e ’80: hanno avuto accesso a nuove libertà, hanno studiato, lavorato, costruito relazioni più orizzontali, spesso hanno avuto figli più tardi rispetto alle generazioni precedenti. Hanno investito molto nella loro realizzazione personale e professionale, ritrovandosi poi – nel pieno della maturità – a gestire contemporaneamente:
- Figli adolescenti, nel pieno della spinta separativa;
- Genitori anziani, spesso malati, con un crescente bisogno di assistenza;
- I primi segnali della menopausa o della perimenopausa;
- Una revisione profonda della propria identità femminile, relazionale e lavorativa.
È una fase esistenziale ad alta densità emotiva, in cui i compiti evolutivi si affastellano: non si tratta solo di fare, ma anche di pensare, sentire, rielaborare. Spesso in solitudine, spesso con il fiato corto. C’è una stanchezza “che non passa dormendo”, un senso di allerta costante, una fatica non visibile ma profondamente pervasiva.
Turuani descrive questa condizione come un “crocevia” in cui la donna si ritrova a incarnare simultaneamente molteplici Sé: il Sé materno (che resta iperattivo anche quando i figli sono grandi), il Sé filiale (che si confronta con la malattia o la fragilità dei propri genitori), il Sé professionale (che spesso chiede ancora prestazione e presenza), il Sé coniugale, il Sé sociale… Tutti questi sé competono per spazio e attenzione, generando un brusio continuo, difficile da zittire.
La metafora più potente del libro è proprio quella della “compressione”: emotiva, logistica, identitaria. È la donna che deve essere presente ovunque – e sempre nella forma migliore – senza potersi permettere interruzioni, vuoti, pause. Ma questa onnipresenza ha un prezzo: quello dell’autoesclusione. Perché spesso il primo sé che viene silenziato è proprio il Sé personale. Quello che chiede ascolto, che domanda riposo, che ha bisogno di desiderare ancora.
Dal punto di vista clinico, questa fase può essere fertile ma anche critica. Spesso le donne arrivano in terapia in condizioni di esaurimento emotivo, oppure con sintomi depressivi mascherati da attivismo, da insoddisfazione relazionale, da somatizzazioni (disturbi del sonno, del ciclo, dell’alimentazione). E il rischio maggiore è che si banalizzi questa sofferenza come “normale stress”, quando in realtà è il segnale di un sistema identitario sovraccarico.
Alcuni dei nodi clinici più frequenti in questa fase:
- Senso di colpa per non riuscire a “stare dietro a tutto”;
- Lutti psichici legati al corpo che cambia, alle relazioni che si trasformano, all’uscita dei figli dal nido;
- Rabbia inespressa verso partner, figli o genitori, che viene spesso negata o repressa;
- Desideri non più riconosciuti perché non più legittimati;
- Crisi del senso: cosa resta di me, ora che non sono più necessaria come prima?
La collega sottolinea anche l’importanza della sorellanza in questa fase. Non intesa in senso retorico, ma come possibilità concreta di condividere esperienze, di validarsi a vicenda, di alleggerire il peso del confronto individuale. Parole come “stanchezza”, “confusione”, “voglia di mollare tutto” trovano senso solo se possono essere dette e accolte.
Oggi ti svelo un pezzo di me…
Ci sono giorni in cui sento di vivere in apnea. Non è paura, non è ansia nel senso classico del termine. È come se fossi immersa in una vasca colma di cose da fare, da contenere, da attraversare. E l’acqua non scende mai. Mai.
Sono figlia di una madre che da due anni affronta un cancro al terzo stadio, e ogni fase del suo percorso – la diagnosi, la chemio, le attese, le ricadute, i giorni buoni che durano troppo poco – è diventata anche mia. Perché il corpo di mia madre si ammala, ma anche il mio sente. È il mio respiro che si accorcia quando lei non dorme, è il mio stomaco che si chiude quando si parla di “nuove metastasi”, sono i miei muscoli che si tendono mentre firmo i consensi informati, e non farei il mestiere che faccio se non avessi il mio vulnus nell’inversione dell’attaccamento
E poi ci sono le mie figlie. Due adolescenti straordinarie: autonome, mature, affettuose. Mi aiutano, mi leggono negli occhi, capiscono i miei silenzi. Eppure sono ragazze, giustamente vive. Vogliono uscire, ballare, avere una vita. E io – che vivo questo periodo come una lunga notte bianca dell’anima – mi ritrovo a dover “tenere sveglio il cuore” anche per loro. Non riesco a dormire davvero finché non tornano. Non per mancanza di fiducia. Ma perché la mia testa non si spegne più. È come se fossi sempre accesa per qualcuno.
Leggendo Le schiacciate di Laura Turuani si scopre che tutto questo ha un nome. Che c’è una generazione di donne, la mia, che si ritrova esattamente a questo incrocio: genitori che si ammalano o si spengono piano, figli che crescono e si allontanano, il corpo che cambia, i desideri che si ridisegnano. Non è solo fatica. È anche perdita. E un senso sottile, ma persistente, di lutto.
Il lutto della giovinezza che sfuma.
Il lutto del corpo che non risponde più come prima.
Il lutto di relazioni che forse non sono più quelle che ci immaginavamo.
Il lutto di un progetto di vita che ora ha bisogno di essere riaggiornato, se non proprio riscritto da capo.
Turuani la chiama “generazione sandwich”. E io mi ci sento tutta, in quel panino un po’ molle e un po’ salato. Da un lato l’accudimento per chi ci ha dato la vita, dall’altro la responsabilità di accompagnare chi quella vita la sta appena scoprendo. E in mezzo, noi: donne a metà strada tra ciò che eravamo e ciò che non abbiamo ancora deciso di diventare.
Mi capita di pensare: e io, dove sono finita in tutto questo?
Perché sì, sono psicologa, madre, figlia, donna… ma chi sono io quando mi siedo, finalmente sola, su quel divano in silenzio? Quella che si commuove senza sapere bene perché? Quella che sa consolare tutti ma non riesce sempre a chiedere conforto?
Nel libro c’è un passaggio che mi ha colpita profondamente: quando si parla del brusio continuo del Sé materno, quell’identità che non si spegne mai, nemmeno quando i figli sono cresciuti. È vero. Anche quando non sei più necessaria in modo pratico, lo sei in modo simbolico.
Non sono ancora in menopausa, ma ci siamo capite. Il corpo cambia, si gonfia, si stanca. La mente ogni tanto si confonde. E la pazienza ha preso il vizio di fare le valigie senza avvisare. È una premenopausa emotiva, più che biologica. È un tempo in cui tutto si muove senza una direzione chiara.
Eppure – e qui arriva la parte tenera, quella che mi salva – qualcosa in me resiste. Come se, proprio in mezzo a questo spaesamento, si stesse facendo largo una nuova me. Più stanca, certo. Ma anche più lucida. Più selettiva. Più vera.
In questo tratto della vita non posso fare tutto. E forse, non voglio nemmeno provarci. Non voglio più essere quella che regge tutto, quella che sa cosa dire, quella che non ha bisogno di niente. Voglio essere quella che sbuffa. Che chiede. Che dice “oggi no”.
Voglio rallentare. Non solo perché la stanchezza mi impone un ritmo nuovo. Ma perché, forse, è tempo di ascoltarmi. Di capire se c’è qualcosa che posso lasciar andare, per fare spazio a ciò che ancora non conosco di me.
È in questi passaggi che la sorellanza di cui parla Turuani diventa reale. Non solo tra amiche, ma tra donne che si guardano, si riconoscono, si dicono a mezza voce: “Anche io. Anche io mi sento così.” Ed è già tanto.
Schiacciata, sì. Ma con dignità.
Con ironia. Con un filo di rossetto, anche se oggi non ho voglia di metterlo. Con lo sguardo più tenero e gentile che posso verso me stessa.
E con una promessa: che nonostante tutto, non mi dimenticherò di me.
E nel frattempo continuo a lavorare. A immergermi nelle storie delle persone che arrivano da me con il bisogno – a volte muto, a volte gridato – di essere ascoltate, comprese, viste con uno sguardo nuovo. Faccio spazio alle loro ferite e ai loro desideri, ai momenti di crollo e a quelli di risalita. E anche se a volte arrivo in studio o con la stanchezza addosso come un cappotto pesante, quello spazio resta per me un luogo vivo. Un luogo di senso. Anche se a volte mi tocca cancellare e riprogrammare l’agenda considerando gli orari di vista in ospedlae o gli accopagni alle terapie..
Immagino che possa sembrare paradossale, ma accogliere gli altri è ancora una forma di ossigeno. Come se, nel restituire presenza e sguardo, ritrovassi anche una parte mia che si disperde nella nebbia.
Ossigeno, è indubbio è anche guardare le mie figlie. Le adoro. Le osservo mentre si affacciano alla vita con quell’entusiasmo contagioso che solo la giovinezza sa avere: i loro progetti, i campi scout, gli stage di danza, il volontariato, i concerti, le uscite in discoteca. E anche se a volte mi tolgono il sonno, mi danno vita.
Mi ricordano che c’è un domani che non dipende solo da me. E che crescere, anche per me, può voler dire lasciarle andare, accompagnarle con fiducia e un pizzico di malinconia.
E in fondo, mentre le guardo danzare verso il futuro, sento che forse anche io posso tornare a muovermi. A ritmo mio. Con passo più lento, sì. Ma ancora mio.
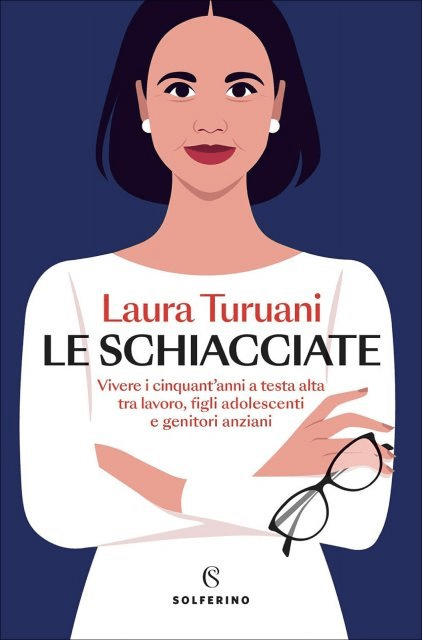


Lascia un commento